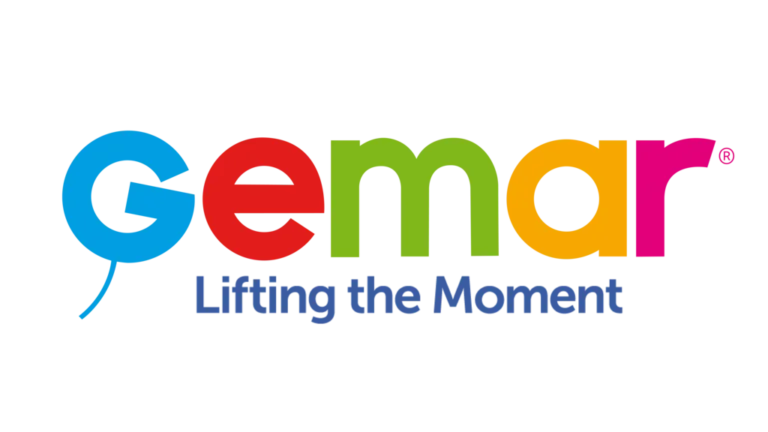Sia chiaro. Io i sacerdoti li rispetto tutti, che indossino il vestaglione alla don Camillo, che girino in clergyman ovvero che vestano come un monopattinista. E tuttavia quello del look up to date dei preti è forse uno dei legati peggiori del Concilio Vaticano II. Dice: l’abito non fa il monaco. Anzi. E’ bene che egli si acconci come qualunque altro comune mortale. In questo modo si avvicinerà di più alla gente, mostrandosi per ciò stesso capace di relazionarsi al meglio con essa. Mi permetto dissentire e ne eviscero i motivi.
Per veicolarci le sue grazie “ex opere operato”, nostro Signore ha deciso di legarle ad un segno tangibile, un segno che, pur essendo in se stesso materiale, produce infallibilmente una grazia spirituale. Ebbene, questo segno non può che assumere le sembianze riconoscibili di un vestimento. Che sia la talare, o il saio, o la tunica punto o poco cambia.
Il consacrato è, o dovrebbe essere, il primo ad aver bisogno della veste sacra, di un segno esteriore che gli ricordi il suo stato di vita. In molti seminari, i candidati ai sacri ordini dormivano con l’abito talare piegato e deposto sul petto. E non si trattava, come alcuni sostengono, di un semplice “memento mori”, ma della logica applicazione del principio secondo cui l’abito religioso serve anzitutto al sacerdote per riconoscere se stesso.
Da ultimo. Un prevosto vestito come un laico qualsiasi, in una Chiesa che da corpo mistico di Cristo rischia di trasformarsi in una Onlus più attenta alle cose del mondo che a quelle dello spirito, corre il rischio di essere scambiato più per un assistente sociale che per un ministro di culto. E allora lasciate che io mi profonda in elogi verso quei pochi ministri di Dio che hanno ancora il coraggio di vestire la talare al modo dei pastori d’anime sanamente tridentini. Chesterton ne sarebbe soddisfatto.