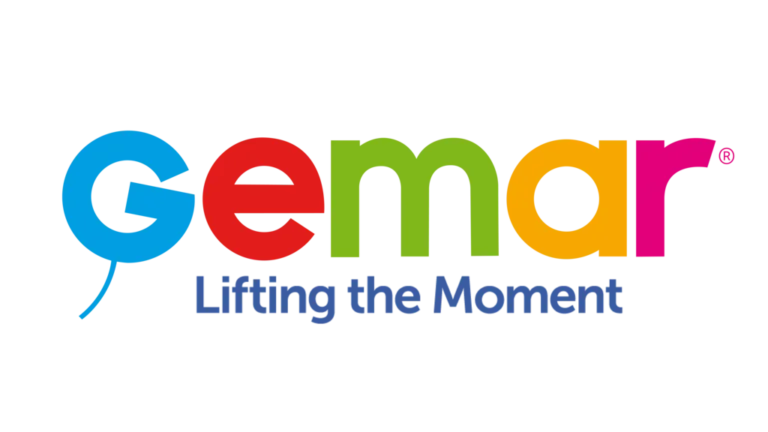La bonifica pontina, un centinaio di anni fa, ha avuto come propulsore la forza lavoro veneta: famiglie spinte da fame a miseria, dopo la prima guerra mondiale, a cercare lavoro al Sud. Dove poi sono talvolta rimasti, spinti dal salto sociale da mezzadri a fondatori di piccole aziende agricole e zootecniche, con passaggi di proprietà che si conclusero però solo negli anni Settanta. A ripercorrere questa epopea dei bonificatori è un incontro promosso nel padiglione della Regione Lazio della 38/a Mostra Agricola Campoverde, in corso ad Aprilia fino al 4 maggio, con tanto di degustazione di un piatto simbolo della cucina dei coloni, il tastasal, correlato al rituale dell’uccisione del maiale, come precisa lo chef, di origini venete, Massimo Spadon del ristorante Il Ritrovo di Borgo Carso (Latina) che ha utilizzato riso Vialone nano veronese Igp, carne di maiale e pepe. “Per ottenere un podere – fa sapere Alberto Panzarini, presidente dell’associazione “Veneti del Lazio in Agro Pontino” – occorreva garantire quattro unità di forza lavoro: i maschi in età 18-60 anni, venivano valutati uno; le donne 055; i ragazzi dai 13 ai 17 anni 0,25″.
I PRIMI COLONI
I primi coloni sono arrivati alla stazione di Cisterna, perché Latina doveva ancora essere fatta. Lì c’era il direttore dell’operazione combattenti che esaminava i documenti. Questo direttore veniva chiamato “L’angelo del destino” perché, dopo che aveva interrogato il capofamiglia, metteva un numero sulla pratica e quel numero era il numero del podere fondiario. In totale vennero assegnati 2.953 poderi, di cui 1.450 quelli conferiti ai Veneti, tra questi 340 provenienti dalla provincia di Treviso, 276 della provincia di Padova, 23 da Rovigo, 230 da Vicenza, 221 da Verona, 125 dalle campagne veneziane. Il regime considerava i Veneti coloni ideali, in quanto fedeli patrioti e lavoratori resistenti alla fatica. Parliamo di circa 15.000 persone esodate in questa area desolata e salmastra con un rapporto di mezzadria e un libretto economico a famiglia che fissata la somma di 1.200 lire ad un’unità lavorativa. Per sfamarli veniva data la farina di polenta. Si mangiava polenta – racconta – sette giorni la settimana, dal lunedì al sabato coi fagioli borlotti, la domenica coi fagioli cannellini. La prima felice contaminazione gastronomica fu un piatto di polenta coi gustosi gamberi di fiume locali. Le donne, oltre a lavorare nei campi, avevano da sfamare a tavola 10-15-20 persone e farsi carico della cura degli anziani; sono state sostanzialmente delle vere eroine. Solo nel 1935 venne concessa la possibilità di avere un orto ed animali da cortile. Ma queste concessioni venivano annotate sul libretto economico e quando veniva effettuato il raccolto veniva scontato dall’ammontare della vendita dei prodotti agricoli. C’era una regola persino sul latte: i bambini sotto i 13 anni potevano avere un mezzo litro di latte mentre le persone anziane, dopo i 65 anni, mezzo litro di latte e gli ammalati un libro di latte. Insomma, era dura andare avanti.
IL DOPO GUERRA
Finita la seconda guerra mondiale, questa fu una storia dimenticata non più insegnata sui libri di scuola, quasi se ne dovessimo vergognare. “Non è così – sostiene Panzarini – perché questa è una storia scritta da gente che ha contribuito a costruire sostanzialmente quello che di bello abbiamo in Agro Pontino e sono dovuti passare molti anni prima di essere riabilitati. Anche grazie alla visita dapprima del presidente della Repubblica Sandro Pertini Sandro Pertini al prefetto in occasione del 50° anniversario di Latina, e successivamente alla concessione da parte del presidente della Repubblica Ciampi della medaglia d’argento al valore civile ai bonificatori che riabilitò definitivamente questa storia”, poi raccontata nel docu-film ‘Stranieri in patria’ della Regione Veneto e da 35 anni dalla stessa associazione “Veneti del Lazio in Agro Pontino” che a maggio ha programmato incontri con le scolaresche e nuove proiezioni.