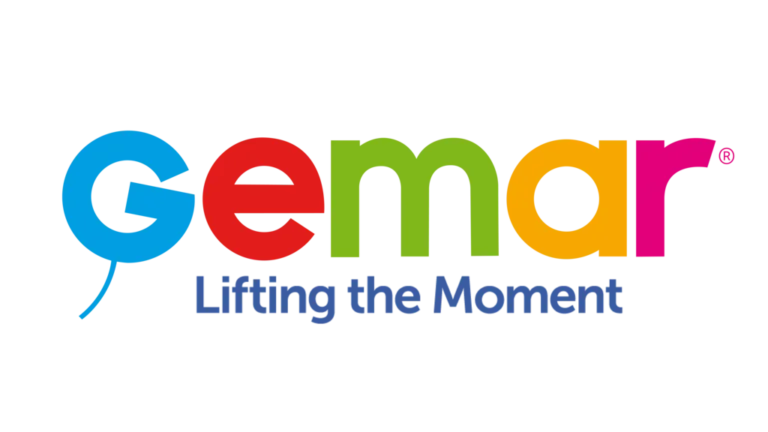Quello della disinformazione è un fenomeno antico. Per dirne una. Ottaviano, figlio adottivo di Cesare, già un paio di millenni ideava slogan taglienti scritti sulle monete, qualcosa paragonabile ad arcaici tweet, per diffondere la notizia secondo la quale il suo acerrimo rivale, Marco Antonio era un soldato romano fallito: un donnaiolo dedito all’alcol e non certo adatto a guidare l’Impero, anche e soprattutto perché corrotto a causa della sua storia d’amore con Cleopatra, regina di un oscuro e lontano Paese straniero. Naturalmente non era vero ma tant’è.
Oggigiorno, questa naturale predisposizione di noialtri bipedi alla diffusione intenzionale di notizie o informazioni inesatte o distorte allo scopo di influenzare le azioni e le scelte di qualcuno ha assunto caratteristiche inquietanti considerata la mole smisurata (infopollution l’avrebbe definita Solženicyn) di notizie. La disinformazione è diventata un mostro tentacolare che si allarga a macchia d’olio e che può contare su una rete di fiancheggiatori, più o meno consapevoli, molto nutrita. Dalla politica che ha scelto le fake news come nuova forma di propaganda, al giornalismo tradizionale che, travolto dalle nuove tecnologie e dalla competizione con le dinamiche del web, sta rincorrendo sensazionalismo e clic spesso a scapito della veridicità e della qualità delle notizie, fino all’enorme potere di mediazione delle piattaforme, nuovi arbitri (interessati) della verità. Si parla di questo nell’ultimo, interessante saggio di Matteo Grandi “La verità non ci piace abbastanza” (Longanesi, 288 pagine, euro 16,90).

“Credo che il virus della disinformazione sia il male del decennio – sostiene l’autore -. Un male alimentato non più soltanto dalle fake news, ma da un corto circuito in cui anche il giornalismo spesso amplifica il caos attraverso superficialità e titoli clickbait (acchiappaclic) in cui gli algoritmi dei social network e dei motori di ricerca condizionano e a volte deformano il nostro rapporto con l’informazione, in cui i politici usano sempre più spesso la scorciatoia della mezza notizia se non della menzogna conclamata per aumentare il consenso, in cui la libertà d’espressione è minacciata dalle piattaforme con l’alibi, paradossale, di voler contrastare proprio la disinformazione”.
E’ in questo contesto che Grandi ha avvertito l’esigenza di raccontare e analizzare i punti deboli del sistema. Da fruitore della notizia, più che da addetto ai lavori. Cercando di riflettere più che di giudicare. Di farsi delle domande più che far cadere dall’alto delle risposte. E cercando di offrire qualche strumento in più per difendersi da questa deriva. Come? Prima di tutto sforzandosi di riportare il tema della rete brutta e cattiva sui binari dell’oggettività. “La rete è solo uno strumento neutro – dice -. Buona o cattiva dipende dall’uso che se ne fa. Per esempio Internet è spesso un alleato prezioso per smascherare le bufale (la pratica del debunking in italiano più o meno smascherare le notizie fasulle, ndr)
Grandi individua la strada maestra nella riattribuzione di una dignità al giornalismo “magari basando l’informazione su nuovi modelli di business slegati dal clickbait ma a un’informazione di qualità a pagamento anche in rete, sul modello del New York Times”.

Creando in altri termini “cultura della rete e consapevolezza attraverso percorsi di educazione digitale. Riscoprendo lo spirito critico. E imparando a difenderci da soli. Se usciamo dal perimetro dei nostri pregiudizi il web ci mette a disposizione tutti gli strumenti per informarci al meglio e contrastare la disinformazione”.
E qui siamo al punto. Le responsabilità che toccano a noialtri comuni mortali travolti dall’infodemia. Come difendersene?
“Prima di imparare a riconoscere le bufale – ha spiegato l’autore – dovremmo imparare a non condividere nessuna notizia se non abbiamo avuto tempo e modo di verificarla e se non siamo assolutamente certi della sua veridicità. La difesa dalla disinformazione non potrà mai essere collettiva, ma deve essere individuale. Acquisire conoscenza e consapevolezza, verificando, attingendo a più fonti, mettendo in discussione i nostri pregiudizi, uscendo dalle sabbie mobili della polarizzazione, prendendo atto che la verità può anche essere diversa da quella che vorremmo sentirci raccontare, imparando a diffidare e al tempo stesso a riconoscere i soggetti affidabili. Non è semplice – conclude – e può richiedere un impegno al quale, come meri fruitori delle notizie, non eravamo abituati. Ma è l’unica soluzione che abbiamo. E ne vale la pena”.